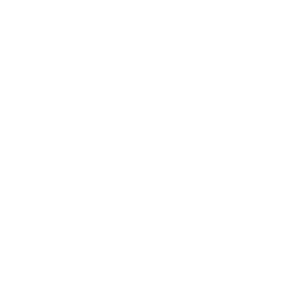Fulvio Roiter, fotografo per eccellenza della città lagunare, racconta i suoi 85 anni vissuti con la macchina fotografica sempre al collo
Ne La Mia Venezia, il suo libro fotografico per antonomasia, definisce la città lagunare “follia dell’ingegno umano […] nata sull’acqua dalla paura”. Ritrarla senza cadere nell’abituale, partendo dall’essenzialità del bianco e nero, per giungere al trionfo del colore, è stata la sua sfida per mezzo secolo. Fulvio Roiter è stato definito “fotografo ufficiale di Venezia” ma a lui basterebbe «fotografo di Venezia. È già molto così» dice. Ad 85 anni continua a studiarla e si racconta.
Dove e quando inizia il suo interesse per la fotografia?
«A Meolo, dove sono nato e cresciuto, feci le prime prove. Ma la scintilla scoppiò andando a scuola a Venezia in Campo San Stino. Alla sera le vetrine e le luci erano una meraviglia che solo l’abitudine può uccidere. Mi stupisco di come, dopo cinquant’anni, riesco ancora a scoprire questa città».
Quindi i primi passi li mosse a Meolo?
«Adoravo i reportage di viaggio: foto unite a narrazione sono un connubio che da sempre ritengo meraviglioso e apprezzavo molto il fotogiornalismo tedesco. In casa trovai una Billybox molto primitiva, ma ai ritiri estivi a Possagno partivo per il Resegon e le zone del Tempio per sfogarmi a far scatti con un’Alfa Isolette di un nostro cappellano. Cercavo nuovi stimoli e nel ‘46 mio padre mi regalò una Welta, anche se io bramavo la Leica. Un giorno, la Gazzetta Veneziana indisse un concorso. Decisi di partecipare con una foto della grata di cinta ghiacciata dell’orto della Chiesa di Meolo: che successo! Questo mi portò a volere un confronto con chi aveva la mia stessa passione e, per assurdo, nella latrina di casa, trovai la pagina de Il Gazzettino che annunciava la nascita del circolo fotografico La Gondola vicino al Ponte de La Paglia».
Un’esperienza fondamentale…
«Certo! Lì conobbi mio padre putativo: Paolo Monti. Vi portai i primi lavori: stampe 7X10 che facevo sviluppare in un negozio di ottica e fotografia in Lista di Spagna che non erano proprio di buona qualità e addirittura bordate con un merletto tagliato con una forbice zigrinata! Poi Gino Bolognini m’insegnò a stampare e sviluppò in formati 30X40 anche scatti precedenti al nostro incontro».
Preferiva qualche soggetto o scorcio?
« I fotografi del Fotoform, in particolare Hammarskjold, coi suoi toni marcati, essenziali, precisi credo mi abbiano influenzato inconsciamente. Il mio occhio cercava l’essenziale, ma volevo fotografare anche Venezia ed ogni suo particolare».
Questo richiese più studio?
«Diciamo un percorso più articolato. Al ponte dei Dai, c’era un negozio di fotografia di armeni che ricevevano il bollettino delle novità della Guilde du Livre di Losanna che stampava in maniera proverbiale libri di fotografia. Davano chance anche a fotografi sconosciuti, così chiesi a mio padre un’ultima possibilità per andare in Sicilia: la fotografai in lungo e in largo e inviai alcune foto a Losanna. Mi risposero chiedendomi di usare delle foto di bimbi siciliani per un libro di racconti e cominciammo una collaborazione. Vedendo alcuni reportage, proposi Venezia e nel ’54 pubblicarono Venise a fleur d’eau dove presentavo un modo nuovo di vedere Venezia in cui carpivo tutto in funzione della luce: dalla gente al vivere sull’acqua».
Cosa lo propose a livello internazionale?
«Il Premio Nadar del ’55 col libro sull’Umbria: Ombrie. Terre de Saint Françoise, ma fu molto apprezzato anche il reportage sull’Andalusia del ’56 in cui sperimentai per la prima volta il colore. Ogni successo era un impulso a spingermi oltre. Ma vedere altre terre serviva a ricaricare le pile e tornare a Venezia con occhio nuovo: quando pensai di essere sul punto di morire nel Mato Grosso, sentivo l’odore della salsedine dei rii lagunari».
Stima altri fotografi nel territorio?
«Zannier come storico e ricercatore della fotografia di cui però non condivido alcune scelte stravaganti nell’osservare lavori altrui e il mestrino Beppi Bruno. I suoi bianco e nero di Venezia e Colli Euganei lo facevano essere uno dei pochi: tutti gli altri imitavano».
Come vede il passaggio al digitale?
«Dovrebbero praticarlo solo i fotografi che hanno molta dimestichezza nel cogliere il momento magico perchè permette di scattare e vedere subito il risultato. La visione immediata non fa avere la tensione necessaria al miglioramento nel saper cogliere. Spero di vivere abbastanza per vedere quanto ancora la tecnica fotografica verrà semplificata».
DI ELEONORA SPERANZA NALESSO

Arte e Cultura +
IL FOTOGRAFO DI VENEZIA
27 Aprile 2011

Tag: fotografia, Venezia