Nato a Treviso negli anni ’30, il mascarpone ha dato vita al tiramisù e conquista ogni Natale sulle nostre tavole
Panettone e pandoro, ma non solo. Sono tanti i dolci e le preparazioni alimentari legate al Natale che, in ossequio alla tradizione, torneranno tra poco meno di un mese sulle nostre tavole in occasione delle festività.
Tra i cibi “natalizi”, rientra indubbiamente a pieno titolo anche il mascarpone.
Ovvero quel “prodotto agroalimentare tradizionale italiano” (questa la classificazione ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, che per le sue caratteristiche peculiari non lo inserisce invece nella categoria dei “formaggi”) che la maggior parte di noi conosce principalmente come ingrediente fondamentale di una delle specialità dolciarie nostrane più apprezzate nel mondo: il tiramisù. Legame, questo, che potrebbe essere ancor più forte di quanto si possa immaginare.
Perché, sostiene la Confraternita del Mascherpone 1933, sarebbe proprio nella prospettiva dell’utilizzo per la realizzazione di questo dolce che sarebbe nato lo specifico prodotto caseario.
Il “mascherpone” è veneto
A sostegno della tesi, c’è un documento risalente a quasi un secolo fa, riportato alla luce grazie al lavoro dello storico Giovanni Toffolatti, citato per provare le radici trevigiane del mascarpone. O, meglio, “mascherpone”, come risulta nel marchio depositato da una latteria trevigiana, e non da produttori di quella bassa lombarda a cui ne viene fatta risalire tradizionalmente la paternità. Quella della nascita del mascarpone è del resto una storia non facile da ricostruire, come tutti gli usi e le tradizioni tramandate fino a un certo punto solo in forma non scritta.
Di sicuro, la produzione e il consumo di un latticino di questo tipo nell’area soprattutto del Lodigiano e del Pavese avviene da secoli. E anche il nome del prodotto ha origini nebulose, legandosi probabilmente al termine dialettale “mascherpa” (ovvero “panna”, ma anche “ricotta”), cognome diffuso nella stessa area lombarda. C’è però anche chi lo lega alla storpiatura di “mas que bueno” (“più che buono”), che sarebbe stato pronunciato da un nobile spagnolo dopo averlo assaggiato nel periodo della dominazione iberica di Milano. Il famoso giornalista e scrittore Gianni Brera, sposando la forma in “he” anziché quella usata oggi, sosteneva invece il collegamento con una presunta “Cascina Mascherpa”, nella Bassa padana.
“Ma questo prodotto non c’entra niente con l’odierno mascarpone”, sottolinea Remigio Villanova, presidente della Confraternita fondata nel 2022 a Cison di Valmarino, proprio in seguito alla riscoperta del documento, il primo scritto ufficiale sul tema, datato 2 ottobre 1933. Fu quel giorno, infatti, che Remo Dolce, allora direttore della latteria della piccola realtà del Trevigiano, registrò il marchio “mascherpone” al Ministero delle Corporazioni di Roma.
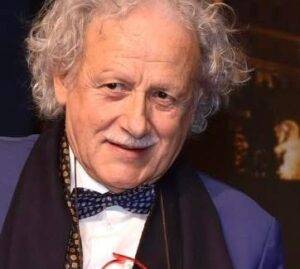
Mascherpone e tiramisù: una storia di successi legati a doppio filo
Ma non finisce qui. Perché la vicenda va inserita nella ben più nota querelle sulle origini del tiramisù.
“Nel 1933 – riprende Villanova – Dolce riuscì a produrre l’elemento base per la nascita del moderno mascarpone. E lo fece proprio pensando al tiramisù”. La tradizione di lunga data nella produzione locale del mascarpone gioca dunque a favore della tesi (sostenuta tra gli altri dal famoso pasticciere Iginio Massari) che attribuisce al Trevigiano l’invenzione del tiramisù.
Anche se una leggenda racconta di un predecessore del dolce nella “zuppa del duca” offerta a inizio del XV secolo a Cosimo de’ Medici in occasione di una sua visita a Siena, sono Veneto e Friuli Venezia Giulia a contendersi il primato. E, sebbene non si tratti di storia così risalente nel tempo, visto che la ricetta non compare nei libri di cucina prima degli anni ’60 del Novecento, le versioni sull’invenzione del tiramisù come lo conosciamo oggi sono diverse.

La fin qui più accreditata punta sul ristorante “Le Beccherie” di Treviso, nel periodo tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70, pur venendo indicati anche altri locali del capoluogo della Marca. La risposta friulana punta invece sulla “coppa Vetturino”, proposta negli anni ’40 nell’omonimo ristorante di Pieris (Gorizia), o sul dolce dell’albergo “Roma” di Tolmezzo, in Carnia, degli anni ’50. “Così come quella dell’origine lombarda del mascarpone – taglia corto il presidente della Confraternita – anche queste sono per noi tutte storie da sfatare: un obiettivo che ci poniamo per il prossimo anno, quando vogliamo proporre in Regione e poi diffondere il disciplinare del vero tiramisù trevigiano. Perché, ancor prima che il dolce venisse proposto già confezionato ai clienti a Treviso, negli anni ’30, in casa Brandolini, ognuno si componeva sul proprio piatto il tiramisù usando tra l’altro, insieme al mascarpone, i biscotti Colussi e il caffè Florian”.
La confraternita “Mascherpone 1933” e la storia della latteria di Cison
Forte dell’orgoglio legato alla scoperta dello storico documento, la confraternita “Mascherpone 1933” è del resto un’associazione che si è posta espressamente l’obiettivo di “diffondere a livello nazionale e internazionale il grande valore identitario culturale ed economico del nostro territorio”. Per celebrare “l’eredità lasciateci nei secoli dall’operosità e dalle fatiche dei nostri vecchi”, si contribuisce così a diffondere la storia della latteria locale, fondata nel 1882 dal conte Girolamo Brandolini d’Adda.
 Facendo nascere la prima latteria sociale del Trevigiano, l’allora senatore del Regno d’Italia puntava espressamente a creare una realtà strutturata attraverso cui alzare il livello della qualità dei prodotti caseari di Cison. Un progetto che raggiunse i suoi migliori risultati e una crescita significativa a partire dalla fine degli anni ’20 dello scorso secolo.
Facendo nascere la prima latteria sociale del Trevigiano, l’allora senatore del Regno d’Italia puntava espressamente a creare una realtà strutturata attraverso cui alzare il livello della qualità dei prodotti caseari di Cison. Un progetto che raggiunse i suoi migliori risultati e una crescita significativa a partire dalla fine degli anni ’20 dello scorso secolo.
L’apice fu raggiunto nel 1943, quando non solo il “Mascherpone” Valmarino, ma anche altri prodotti di punta come il burro, la casatella e la “Rosa nelle Alpi” raggiunsero le tavole di tutta Italia e furono esportati anche all’estero, arrivando fino all’Egitto. Dopo la fuga dall’Italia di Remo Dolce, la latteria si avviò alla decadenza, chiudendo definitivamente nel 1970. A raccoglierne l’eredità, la vicina Latteria di Soligo, oggi custode dei prodotti caseari tradizionali della zona. Tra cui, appunto, il mascarpone.
Alberto Minazzi




