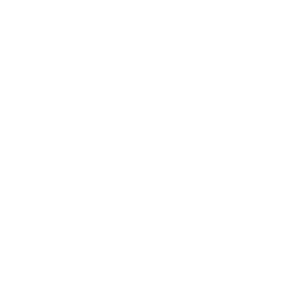Le notti veneziane, l’amato sassofono, la passione per la musica. Ritratto inedito in quattro tempi del capitano dell’Umana Reyer, che si racconta come non ha mai fatto prima. Tra sorrisi, ricordi e una vena di blues
E’ stato il primo capitano non italiano della Reyer in 140 anni di storia. Da tre anni è la pietra angolare di ogni vittoria e l’ancora di salvezza di ogni risalita. «Se quando sei in campo fingi, o fai certe cose solo per cercare l’applauso, la gente lo sente. Cerco semplicemente di essere onesto e dare tutto in ogni mio gesto». Alvin Young è più di un giocatore. Trascina, scuote, frena, spinge, carica. C’è qualcosa di visceralmente musicale nel suo modo di stare in campo e di essere leader. La musica del resto è la sua grande passione, che addirittura insidia quella per la pallacanestro. Per questo proviamo a farvi vedere il capitano dell’Umana Reyer sotto una luce diversa, raccontandovelo in musica. In quattro quarti, un ritmo che – forse non a caso – è anche quello che scandisce il tempo nel basket.
(1° QUARTO) BROOKLYN BLUES. Non si può raccontare Alvin Young senza partire da dove è nato e cresciuto. La famiglia, i fratelli, il playground, il quartiere. Il sogno da bambino: avere una cameretta tutta per sé. Quando si parla di Brooklyn una vena di blues attraversa il sorriso di Alvin. Quando ci parla della sua vita prima del basket, lo fa con pudore sincero. Gli affetti, gli amici, ma anche un quartiere dove a volte basta poco per svoltare nella strada sbagliata. Non lo dice, ma lo fa intendere: il basket è stata la sua grande opportunità. Che non avrebbe probabilmente colto senza mamma Edna.
Perché tua madre ti ha spinto tanto per farti uscire di casa e accettare le offerte che ti erano arrivate dall’università? «Voleva che andassi via, che cambiassi aria. Sai, quando sei poco più che un ragazzo vuoi fare quello che fanno gli altri. E invece mi ha spinto a intraprendere questa strada, credeva nei miei mezzi molto più di me. Non ho giocato a basket ai tempi dell’high school. Non avevamo i soldi per il college, ma quando mi hanno offerto la possibilità di andarci, lei mi ha subito incoraggiato, mi ha spronato a crederci. Ha sempre creduto in me e ha sempre pensato che il talento per questo gioco mi avrebbe potuto aiutare. Tutto quello che ho fatto dopo lo devo a lei. Quando è morta, poco prima che iniziasse il mio ultimo anno di college, per me è stato un momento durissimo».
Hai tre fratelli. Ti assomigliano? «Io sono l’ultimo dei quattro, il più piccolo. Il primo è mio fratello maggiore, il “custode” della famiglia, verso cui è molto protettivo. Poi ci sono le mie sorelle: una mi assomiglia, ride e scherza proprio come me, l’altra è più riservata».
Brooklyn significa anche playground. «Sono cresciuto nel campetto della chiesa dove lavorava mia mamma. Tra i miei idoli c’era Biz, uno dei giocatori più forti dei playground della zona. Da piccolo volevo essere come lui!»
E quel tiro ad “arcobaleno” da dove viene? «Proprio a quei tempi. Quando giocavo contro Biz, io ero piccolino e lui mi stoppava sempre. Così mi sono dovuto inventare questo tiro per anticiparlo ed evitare che ogni volta mi ricacciasse indietro il pallone…»
Ai tempi dell’università eri considerato un giocatore da “playground”. Ora sei un giocatore più “europeo” degli europei. Come hai fatto? «Grazie alle urla dei miei allenatori! In quattro anni di college ho avuto quattro diversi tecnici ed è stato un arricchimento perché con ognuno ho migliorato qualcosa. La questione è che ognuno di noi pensa di essere fatto in un certo modo. Poi trovi chi riesce a farti fare qualcosa di più e di diverso. Così si migliora».
Finito il college a Niagara, hai subito lasciato gli USA. Come mai? «Per avere subito un buon contratto. Avrei potuto giocarmi le mie carte anche in NBA. Avevo fatto il summer camp con gli Indiana Pacers. Ero molto vicino ad un accordo. Ma poter iniziare immediatamente a guadagnare qualcosa mi ha fatto lasciare gli USA. È andata bene comunque. Da giovane però fai scelte impulsive e certe cose le capisci solo dopo».
(2° QUARTO) SUITE EUROPEA. Una carriera lunghissima, una parabola che sembra non voler mai scendere, proprio come i suoi tiri. Merito della dedizione e di un fisico perfettamente integro, anche grazie al fatto di aver iniziato tardi a giocare, cosa che gli ha permesso di non mettere troppo presto sotto stress il corpo e la mente. In Europa ha trovato la sua dimensione. Il suo è un felice connubio tra istinto da playground americano e sagacia tattica europea. Ma non tutto è stato semplice, né lineare. Prima l’impatto con nuove pressioni, nuovi ambienti. Poi l’adattamento ad un diverso modo di stare in campo, più riflessivo e rigoroso.
Dopo l’università, destinazione Europa, di preciso in Grecia. Come è stato l’impatto? «Choccante. Una delle prime partite siamo andati a giocarla ad Atene contro l’Olympiacos. Non credevo ai miei occhi. A parte il frastuono, vedevo fumogeni volare da una parte all’altra delle tribune. Poliziotti con gli scudi in assetto antisommossa. In campo ti arrivavano monetine surriscaldate con gli accendini. A fine partita ho chiamato mia sorella: “Qui sono tutti matti, io scappo via e torno diretto a casa”!»
Molti non sanno che il primo posto dove sei arrivato in Italia era Cantù, dove ti aveva voluto Bruno Arrigoni. «È stato proprio così. Sfortunatamente mi sono infortunato ad un ginocchio prima che potesse iniziare il campionato. Ricordo che c’era ancora il grande Antonello Riva. E al posto mio arrivò Bootsy Thornton».
Alla tua crescita di giocatore i tecnici italiani hanno contribuito parecchio, ma ci è voluto tempo. Ad esempio hai detto che all’inizio non capivi Marcelletti. Cosa non capivi esattamente? «Tutto! Devo anche dire che in quel momento non stavo giocando benissimo. Non ci intendevamo proprio. Era una battaglia quotidiana. Un muro contro muro, forse anche perché entrambi avevamo due caratteri forti. Poi ho cominciato a comprenderlo e devo dire che mi ha insegnato moltissimo. Gli sono grato».
Andrea Mazzon, il tuo attuale allenatore all’Umana Reyer, è stato assistente proprio di Marcelletti a Verona. Si assomigliano come allenatori? «In parte sì e in parte no. Marcelletti era un martello, un duro alla Bobby Knight. Mazzon è più un allenatore alla Krzyzewski, è più paziente, è prodigo di spiegazioni. A livello di gioco Marcelletti impostava tutto su due realizzatori e il resto della squadra doveva seguirli. Con Andrea invece si pratica un gioco più libero, fatto di letture e responsabilità diffuse».
Chi è stato il giocatore più forte in assoluto che hai affrontato in Europa? «Alphonso Ford (ex giocatore di Siena e Pesaro, scomparso prematuramente nel 2004 all’età di 33 anni per una grave forma di leucemia, ndr). Grandissimo giocatore. Fisicamente tostissimo. Non riuscivi minimamente a spostarlo. In Italia, Mario Boni. Tremendo tiratore e agonista nato».
Cosa pensi di aver capito degli italiani, che prima non sapevi? «Che sono molto legati agli affetti e alla famiglia. E poi hanno il culto della tavola, del mangiare e dello stare insieme».
Cosa invece non riesci ancora a capire degli italiani, fuori dal campo? «Perché fumate così tanto?»
E nella pallacanestro? «Non capisco la fretta di cambiare. Si cambia troppo spesso e troppo velocemente. La “chimica” invece è importante, è la base di tutto in questo gioco».
Questo conferma come tu ti sia adattato a meraviglia qui in Europa. «Il basket europeo è davvero quello che fa per me, non c’è dubbio. E sai cosa ti dico? Credo anche che sia la prima volta che lo dico! Ma è proprio così».

(3° QUARTO) RONDÓ VENEZIANO. In cima alla lista dei giocatori per salvare la Reyer dal baratro della serie B, Andrea Mazzon aveva un unico nome. Quello di Alvin Young. Attorno a lui è stata costruita la squadra che ha permesso di confermarsi in Legadue e poi di fare il grande salto in serie A. Di quel gruppo è l’unico ad essere ancora in maglia orogranata. Tra lui e i tifosi si è instaurato un rapporto speciale, grazie al suo carattere solare, ma soprattutto alla sua totale dedizione alla causa. Quando serve fermare l’avversario più pericoloso lui c’è. Quando serve prendersi il tiro decisivo, lui c’è. Quando bisogna dare la scossa ai compagni, lui c’è. Quando serve ricacciare indietro la rimonta avversaria, lui c’è. Nei momenti che contano, non manca mai. È nato un legame particolare con Venezia e i veneziani. Una sintonia pari solo a quella di un mito assoluto della storia orogranata come Steve Hawes, che in laguna aveva lasciato il cuore.
Quale è stato il momento più bello da quando sei a Venezia? «Ancora e senz’altro la vittoria contro Veroli in gara-5 di semifinale promozione in Legadue. Per noi giocatori vincere quella partita era come aver conquistato la promozione. È stato un momento magico, grazie anche all’incredibile spinta dei nostri tifosi».
Come ti sei trovato in laguna? «Dopo New York è la seconda città che amo di più al mondo. È semplicemente meravigliosa. Amo venirci la sera. Quando voglio stare un po’ da solo e riflettere, mi metto le cuffie, ascolto la musica e inizio a camminare da solo per calli e fondamenta».
In quale momento ti sei sentito appieno parte della Reyer? «Con la prima vittoria al Taliercio nel girone di ritorno l’anno del mio arrivo. Venivamo dalla partita di Udine dove avevamo perso male. Il primo quarto era stato addirittura drammatico. Dovevamo risollevarci ma non era facile. Contro Casalpusterlengo giocammo una grande partita. E lì sentii davvero addosso questa maglia».
C’era voluto in effetti un po’ di rodaggio per entrare nei cuori dei tifosi. «Ero molto nervoso. Ero reduce dall’esperienza di Pavia poco fortunata. E mi avevano chiamato qui per sostituire un giocatore importante come “Boo” Davis, che era pur sempre il secondo realizzatore della squadra. Sentivo una gran pressione addosso. Volevo dimostrare a tutti i costi che l’allenatore e la società non si erano sbagliati sul mio conto».
Entriamo di nascosto nello spogliatoio dell’Umana Reyer. Chi sono i “re” degli scherzi? «Io per primo, poi ci sono Guido Rosselli e Marconato, che sembra in tipo tranquillo, ma in spogliatoio non manca mai di combinarne qualcuna. E poi c’è Szymon, che parla, parla, parla sempre…»
(4° QUARTO) CONTRO TEMPO. «Ci sono due tipi di persone: quelle che dicono “Io posso” e quelle che dicono “Io non posso”. E sono entrambe nel giusto. Alvin pensa “Io posso”». Nessuno forse lo ha mai descritto meglio del suo ex allenatore Joe Mihalic con questa definizione. Se c’è una cosa che Young ha sempre dovuto fare è stata quella di dimostrare agli altri che si sbagliavano. Al campetto si sbagliavano a pensare che non potesse farcela solo perché era il più piccolo. Al college si sbagliavano a pensare che non potesse farcela solo perché non aveva giocato all’high school. In Europa si sbagliavano a pensare che non potesse farcela perché ormai era troppo vecchio. A far cambiare idea agli altri Alvin si è abituato col tempo. Il risultato è sempre stato lo stesso: un successo.
Di stupire probabilmente non smetterà mai. Gli basterebbe qualche nota del suo sassofono, probabilmente per scambiarlo per un consumato jazzista. Oppure vederlo dietro ad una scrivania, nei panni dell’insegnante, un’altra delle sue attitudini.
Qual è la tua grande passione, basket a parte? «La musica, in assoluto. È una parte fondamentale della mia vita. Spazio tra molti generi, adoro tutti i tipi di jazz. Suono la batteria, ma soprattutto sono affezionato al mio sax».
Come ti vedi tra dieci anni? «Vorrei poter condividere l’esperienza che ho fatto nella mia carriera di giocatore. Mi piacerebbe allenare, anche i ragazzi. Mi piace stare a contatto con le persone, sono nato per stare in mezzo alla gente».
E se un domani la Reyer ti chiedesse di rimanere magari all’interno dello staff tecnico? «Sarebbe un grande piacere, un onore. Non potrei che accettare».
Ma la domanda più importante, che tutti si fanno è un’altra: quando trovi la donna della tua vita e metti finalmente su famiglia? «La sto cercando, giuro che la sto cercando. Solo che faccio un po’ fatica a trovarla… Come dovrebbe essere? Innanzitutto intelligente. Poi sexy. Poi simpatica. E sexy. Forte, ma non troppo. E poi di nuovo sexy. Dici che riesco a trovarla?»
DI ALESSANDRO TOMASUTTI