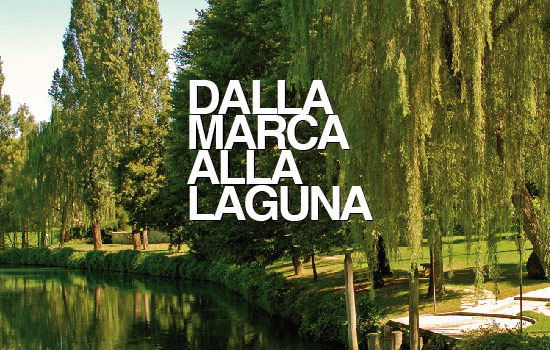Una rete di sicurezza condivisa: via al piano per difendere il suolo e le infrastrutture. Un cambio di prospettiva che mette insieme le città
C’è un filo invisibile che lega le campagne di Padova, le pianure del Trevigiano e la laguna di Venezia: l’acqua. Quando è troppa, diventa un nemico; quando manca, minaccia la vita agricola e la stabilità del terreno.
È lungo questo equilibrio fragile che si muove l’ultima delibera regionale in tema di difesa del suolo ( n. 1160 del 30 settembre 2025, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Veneto a inizio ottobre) che, pur essendo un atto tecnico ha un peso concreto per il futuro di tre province e di chi le abita.
Padova, Venezia e Treviso dovranno infatti ora lavorare insieme anche per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici su una rete di mobilità che connette quotidianamente milioni di persone e merci. L’obiettivo è trasformare gli interventi di difesa del suolo in occasioni di riqualificazione territoriale, puntando su tecniche di ingegneria naturalistica e infrastrutture “verdi”.
Dalla Marca alla Laguna, passando per Padova
La Regione ha approvato uno schema di convenzione con le Province di Padova, Rovigo, Treviso e la Città metropolitana di Venezia per il conferimento di fondi e competenze operative in materia di difesa del suolo. Le amministrazioni locali avranno cioè il compito di realizzare e gestire interventi di manutenzione idraulica, prevenzione del dissesto e controllo del reticolo idrografico minore, con stanziamenti regionali dedicati. La Regione definirà le linee strategiche, ma saranno i territori a muoversi concretamente sul campo.
Il documento stabilisce che i progetti finanziati dovranno rispondere a criteri di urgenza e impatto, con priorità a quelle aree classificate come “a rischio medio o elevato” dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Ogni provincia dovrà presentare rendicontazioni periodiche e relazioni sui risultati ottenuti: una novità che mira a rendere più trasparenti tempi e spese.

Il rischio sotto i piedi
Il Veneto è una delle regioni italiane più esposte a criticità idrogeologiche.
Nel 2024, secondo i dati dell’ISPRA, oltre il 40 % del territorio veneto era classificato come “potenzialmente soggetto a frane o alluvioni”. Ma il dato diventa ancor più preoccupante se si guarda nel dettaglio.
Nel Padovano, i corsi d’acqua minori — Bacchiglione, Tergola, Muson dei Sassi — sono stati più volte protagonisti di esondazioni, con allagamenti nelle aree rurali e nei quartieri periferici del capoluogo. I consorzi di bonifica hanno segnalato un progressivo abbassamento del terreno e un sistema di arginature che, in molti tratti, necessita di rifacimenti urgenti. Il focus è dunque sui corsi d’acqua che attraversano la pianura centrale, con opere di pulizia, rinforzo arginale e riqualificazione delle casse di espansione di Bovolenta e Vigonza. È previsto anche un piano di consolidamento del ponte di Selvazzano, nodo viario strategico ma vulnerabile agli allagamenti.

Cosa prevede il piano di sicurezza
Nel Trevigiano, l’espansione urbanistica e la riduzione delle aree di assorbimento naturale hanno aggravato la vulnerabilità: bastano poche ore di pioggia intensa per mandare in crisi i canali di deflusso e le reti fognarie. Treviso è anche uno dei territori con la più alta densità di “tombinamenti” dei corsi d’acqua, cioè tratti interrati che riducono la capacità di smaltimento. Qui l’attenzione si concentra sul reticolo minore del Sile e del Piavesella, dove il progressivo interramento dei canali ha ridotto la capacità di deflusso. Saranno avviate opere di disostruzione e ampliamento dei tratti critici, oltre alla messa in sicurezza del quartiere di San Lazzaro, colpito più volte da eventi di piena. La provincia ha anche in programma la sistemazione di due frane nei comuni collinari di Vittorio Veneto e Cison di Valmarino.

La Città metropolitana di Venezia, invece, vive una doppia sfida: l’innalzamento del livello del mare e la subsidenza, l’abbassamento del suolo dovuto anche a cause naturali e antropiche. A ciò si aggiunge la complessità della rete lagunare. La delibera cita esplicitamente l’esigenza di “coordinare gli interventi di difesa del suolo con quelli di salvaguardia lagunare”, per evitare sovrapposizioni e sprechi. I fondi stanziati saranno utilizzati quindi per il potenziamento dei sistemi di pompaggio tra Marcon e Mestre, per la manutenzione dei canali di gronda e per il rinforzo di alcuni argini interni del Marzenego e del Dese. In parallelo, verranno finanziati studi di fattibilità sulla subsidenza della gronda lagunare e sugli impatti del cambiamento climatico sulle infrastrutture portuali.
Infrastrutture da proteggere
Non è solo una questione ambientale. Gran parte delle infrastrutture venete (strade, ferrovie, ponti, piste ciclabili) corre lungo o sopra corsi d’acqua minori.
Gli interventi non riguarderanno dunque solo di argini o canali: sotto la lente finiscono anche le infrastrutture viarie e logistiche.
Il primo passo sarà quello di individuare i “nodi infrastrutturali vulnerabili”.
Poi dovrà essere integrata la manutenzione idrogeologica con quella stradale, superando la logica dei compartimenti stagni.
Per la prima volta, i piani di difesa del suolo e quelli di manutenzione stradale verranno affrontati contestualmente: un approccio che punta a risparmiare risorse e ridurre la vulnerabilità complessiva.

Quanti fondi e quali priorità
Secondo il documento allegato, la Regione mette a disposizione oltre 20 milioni di euro complessivi, di cui una quota significativa sarà destinata proprio alle tre province più densamente popolate. Ogni ente dovrà predisporre un piano triennale di interventi, con una prima tranche di lavori già avviabili entro il 2026.
Le priorità saranno la manutenzione dei corsi d’acqua secondari, la messa in sicurezza delle aree urbane a rischio e la sistemazione dei versanti in zone collinari.
La delibera mette in campo una nuova strategia: non bastano opere puntuali, serve una gestione coordinata e permanente non dell’emergenza ma del rischio.
Un laboratorio per il futuro
Il nuovo schema non è dunque solo un atto amministrativo, ma un tentativo di creare un sistema integrato di difesa del territorio.
La sfida consiste nel passare da una gestione emergenziale del rischio a una manutenzione programmata e continua. E coinvolge tutti: i sindaci, i consorzi, i tecnici, ma anche i cittadini.
“Difendere il suolo significa difendere la vita quotidiana: le case, le fabbriche, le scuole, le strade”, ha ricordato l’assessore regionale all’Ambiente durante la presentazione della delibera sintetizzando quella che sembra essere l’ambizione del piano: costruire una rete di sicurezza condivisa che potrebbe diventare modello anche per altre regioni.
Consuelo Terrin